
Martha e Leni hanno trentanove e centouno anni: le loro vite così diverse si incrociano nel 2003 alle Maldive, a Gangehi, un isolotto nel nord-ovest dell’atollo di Ari, nel corso di un’immersione subacquea (della durata di appena un’ora) in cui la più giovane delle due, inquieta biologa marina che custodisce dentro di sé un tragico nodo irrisolto legato a filo doppio al passato della più anziana, assiste la centenaria in quello che sarà il suo ultimo viaggio fotografico nelle profondità del mare. Martha è figlia di una sopravvissuta, l’unica della sua famiglia, allo sterminio nazista delle etnie Rom e Sinti. Helene Bertha Amalie (detta Leni) Riefenstahl, ballerina, regista e fotografa tedesca, è la donna che la potenza plastica e feroce di quel regime l’ha raccontata (e celebrata) nei suoi film.
Con una prosa che è essa stessa un’immersione, tanto fluido è il periodare e cristallino è il lessico, in “Quest’ora sommersa”, edito da Feltrinelli, Emiliano Poddi, scrittore brindisino classe 1975, rappresenta con rara sensibilità umana e politica la promiscuità tra bene e male, raccontando egregiamente la vita dibattuta di un personaggio controverso, del quale la storia, durante il programma di denazificazione successivo alla seconda guerra mondiale, ha celebrato il talento artistico e stigmatizzato le convinzioni politiche (malgrado, dopo ben quattro processi, non vi sia alcuna sentenza di condanna a suo carico per coinvolgimento in attività di guerra o in crimini contro l’umanità).
Poddi è romanziere, autore teatrale e radiofonico di successo, allievo e poi docente di narrazione nella prestigiosa scuola di scrittura e comunicazione “Holden”, fondata da Alessandro Baricco nel 1994 sul modello delle grandi scuole di scrittura creativa statunitensi e ancora oggi esempio straordinario di come il mestiere di scrivere, al di là di ogni talento personale, si possa insegnare e imparare. L’idea di dedicarsi alla scrittura per Poddi arriva tardi: “Ho sempre amato leggere ma no, quand’ero piccolo non volevo fare il romanziere”, precisa. “Volevo diventare un campione di pallacanestro: sono figlio di due cestisti e io stesso ho giocato a livello agonistico per molti anni, sino a quando la cartilagine del mio ginocchio sinistro non si è arresa, dopo quattro operazioni chirurgiche non risolutive”.
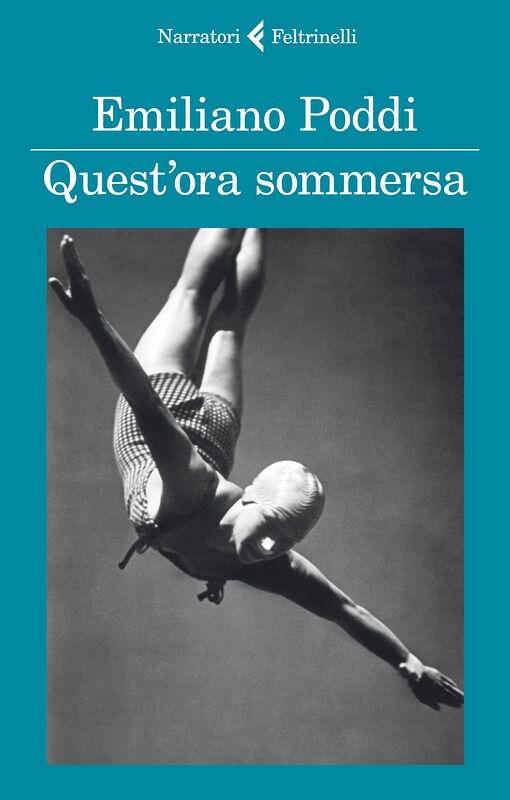
Colei che è universalmente nota come “la regista di Hitler” conobbe il Führer nel 1932, dopo essere rimasta folgorata dalla lettura del Mein Kampf. Su commissione del futuro cancelliere, ammaliato dalla sua tecnica cinematografica e forse infatuatosi di lei anche sentimentalmente, la Riefenstahl girò il cortometraggio “La vittoria della fede”, sul congresso di Norimberga, “Il trionfo della volontà” (vero e proprio manifesto apologetico del nazismo) e “Olympia”, dedicato alle Olimpiadi che si tennero nel 1936 a Berlino e tuttora considerato il suo capolavoro. Il suo lungometraggio più discusso, però, resta “Tiefland”, le cui comparse, prelevate direttamente dai campi di Zigeunerlager e Marzahn, furono, al termine delle riprese, nel 1944, nuovamente internate.
Poddi racconta che l’idea di scrivere di Leni Riefenstahl è maturata sull’onda lunga del romanzo precedente, “Le vittorie imperfette”, che narra, tra l’altro, la finale di basket Usa-Urss alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Più volte, mentre si documentava nel corso della stesura di quel romanzo, ha sentito dire che per i tedeschi Monaco ‘72 rappresentava una sorta di riscatto per l’ignominia di Berlino ’36, le Olimpiadi marchiate con l’impronta del regime nazista e immortalate proprio nel film “Olympia” diretto da Leni Riefenstahl: “Più mi documentavo, guardando il film, e più mi rendevo conto che Leni non era affatto interessata all’aspetto propriamente sportivo delle Olimpiadi. Ciò che le importava era più che altro la rappresentazione della bellezza scaturita dallo sforzo agonistico. Da un lato, mi sono entusiasmato per lo splendore delle immagini perché, attraverso quelle riprese particolarissime, Leni è stata capace di catapultare nella sfera del mito i corpi di questi atleti, così come avveniva nell’antica Grecia. Dall’altro lato, ero deluso perché, in quel film di quattro ore, lo sport era praticamente inesistente. In quel momento ho capito che, più che le Olimpiadi, mi interessava chi aveva concepito quelle immagini. Dopo aver visto “Il trionfo della volontà”, che riprende con toni entusiastici le grandi adunate naziste, ha cominciato a farsi strada dentro di me quella che è poi diventata la domanda centrale del libro: come è possibile che nella stessa donna convivano la bellezza di quel capolavoro cinematografico che è “Olympia” e la vergogna della dittatura hitleriana celebrata in “Il trionfo della volontà”? Da qui sono partito per scrivere”.
È il dissidio tra cultura e orrore di cui parla Hannah Arendt ne “La banalità del male”: Eichmann godeva nell’uccidere a colpi di frusta gli internati, salvo poi passare le serate ad ascoltare i grandi compositori tedeschi di musica classica.
“Esattamente. È una cosa sconvolgente, soprattutto se pensiamo che mentre Eichmann è un semplice fruitore di bellezza e cultura, Leni Riefenstahl è una che la cultura la produce, per cui il conflitto tra i due aspetti mi è sembrato ancora più potente e mi ha portato a riflettere sulla responsabilità di chi racconta delle storie. Ci sono concetti di cui noi narratori ci innamoriamo ciecamente e che poi vengono messi in crisi da storie come questa. Un critico cinematografico di cui adesso mi sfugge il nome una volta ha detto che l’unica morale di un film è il modo in cui viene girato. Non il bene o il male insiti nei personaggi, ma la sua forma. Pertanto, le uniche domande che avrebbero senso sarebbero: è opportuna quella inquadratura? per descrivere al meglio una certa scena serve un campo lungo o un campo stretto? Leni ha sposato questa tesi: non si è mai proclamata nazista. Ha dichiarato di aver girato i suoi film su richiesta di Hitler al meglio delle sue possibilità tecniche ed artistiche, ostentando una totale indifferenza nei confronti dell’oggetto delle sue rappresentazioni. Io, da scrittore, mi chiedo: posso essere indifferente al contenuto delle storie che racconto?”.
Allora come si coniuga questa indifferenza così sfacciatamente esibita con le parole che Leni Riefenstahl disse di Hitler dopo averlo conosciuto: “Ne sono incantata, forse è davvero l’uomo che salverà la Germania”? Probabilmente Leni non era proprio così al di fuori e al di sopra di ciò che raccontava.
“Sono d’accordo, non credo nemmeno io che lo fosse. Il rischio che si corre parlando della Riefenstahl, anche quando la si è studiata molto bene, è incappare in questa contraddizione. È lei che ha sostenuto di essere completamente insensibile al contenuto, salvo poi sperticarsi in lodi esagerate di Hitler e del suo programma di rinascita della Germania. Alcuni studiosi che si sono occupati di lei ritengono che Leni sia rimasta nazista ben oltre la sua collaborazione con Hitler, che è di fatto ben limitata ad un certo periodo storico. Ad esempio, quando lei va in Africa a fotografare i Nuba o quando prende il brevetto di immersione subacquea per fotografare le meraviglie del mondo sottomarino, è possibile che stia ancora inseguendo quell’ideale formale di bellezza e di grandezza che è il fondamento del nazismo. Se lo chiede anche Martha: chissà che non sia, anche questo rincorrere la forma a discapito dei contenuti, una forma di nazismo”.
L’impressione, leggendo il libro, è che attraverso la figura di Martha, lei si sia assunto il compito di “spacchettare” la figura di Leni per mostrarne al lettore i tratti antitetici, senza pretendere di ricondurla ad unità o di risolverne le contraddizioni in modo definitivo.
“Sono molto contento che emerga questa impressione, che è poi il fine ultimo del libro. Quando il documentarista Müller le chiede se è orgogliosa di avere girato “Il trionfo della volontà”, forse in assoluto il film più nazista che sia mai stato girato, Leni gli risponde che no, non lo è, perché quel film le ha cucito addosso l’etichetta ingiusta di nazista e gli ha causato soltanto guai. Un attimo dopo, però, osservandone una scena sullo schermo, non riesce a non confessare quanto abbia amato realizzarlo. Sembrano due persone diverse, ma è la stessa donna. Martha, nel cercare risposte alla sua storia famigliare, coglie queste contraddizioni. Ne resta turbata, ma in un certo qual modo anche sedotta. Esattamente quello che è capitato a me: non si può restare indifferente ad un’anima artistica tanto potente, per quanto la sua adesione agli orrori nazisti me la renda lontana umanamente e politicamente”.
Quanto si può parlare di semplice connivenza e quanto, invece, si dovrebbe parlare di adesione, a proposito del rapporto tra Leni Riefenstahl e l’ideologia nazista?
“Non credo di avere una risposta definitiva a questa domanda. Il grande potere di attrazione della Riefenstahl, che io stesso ho subito mentre ne scrivevo, deriva proprio dall’impossibilità di fissarne una volta per tutte la personalità e le scelte politiche. Un personaggio del genere, dal punto di vista narrativo, è una bomba. Ciò detto, penso che il fascino che Leni ha percepito conoscendo Hitler riguardi prevalentemente la forza dell’uomo, la sua energia e il suo carisma, più che le sue idee”.
Martha e Leni sembrano incarnare le qualità di eroe e antagonista delle storie che ci venivano raccontate da bambini. Secondo lei, malgrado questo, è possibile rintracciare dei tratti di affinità tra le due?
“Penso di sì. Io credo che Martha somigli a Leni nella voglia di seguire sino in fondo un’ossessione. Per la Riefenstahl era quella di creare sino a centouno anni l’immagine perfetta e soddisfare quegli ideali di forma che per l’intera vita ha cercato di rappresentare nelle sue opere. Martha trasforma in ossessione una domanda: perché Leni abbia distrutto l’esistenza di sua madre, condizionando fortemente anche la sua. La determinazione di queste ossessioni molto diverse le rende in fondo simili. Altra caratteristica che le accomuna è l’avere eletto come elemento di riferimento l’acqua, il mondo subacqueo, il che le pone l’una nei confronti dell’altra ad un livello di comunicazione molto intenso, come capita a chiunque sia costretto a comunicare con sguardi e con gesti, cosa che puntualmente si verifica durante le immersioni. Sono elementi di contatto che rendono la loro storia difficile da districare, perché piano a piano quella che all’inizio sembrava soltanto una storia di contrapposizione tra eroe e antagonista diventa molto di più”.
Per scrivere di un personaggio storico normalmente si frequentano gli archivi, lei è andato alle Maldive…
“L’ho scelta proprio per questo! Scherzi a parte, ho sempre pensato che sia fondamentale avere un contatto fisico con i luoghi che si raccontano. Anche per il libro precedente è stato così: ho studiato tanto, poi sono andato a Monaco per visitare il villaggio olimpico e il palazzetto dello sport dove la partita che descrivo si è svolta. In realtà, io ho iniziato a esplorare l’ultima parte della vita di Leni, quella in cui si dedica alle riprese e alle fotografie subacquee, dopo aver prenotato un viaggio alle Maldive con la mia compagna. Ed è stato proprio il viaggio a determinare l’ambientazione della storia, non viceversa. Forse, se non ci fossi andato, avrei parlato di Leni collocandola in un altro contesto”.
Per ricostruire il proprio sé, Martha ha bisogno di incontrare Leni. Capovolgendo la prospettiva, Leni ha bisogno di Martha? In che misura?
“È la domanda che verso la fine del libro Martha stessa si pone. Certamente esiste anche una seduzione al contrario, forse impossibile da prevedere per entrambe le donne. Ma non posso risponderle senza svelare ai lettori il finale del libro, quindi passo”.
Ottimo espediente narrativo, per uno che non voleva fare il romanziere…
«Alla fine un po’ ho imparato…».
