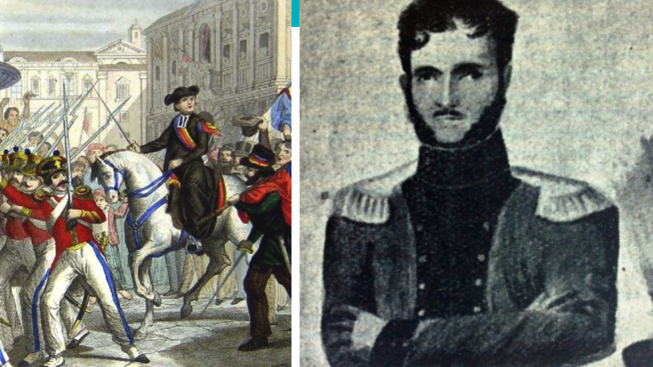
Pur se consolidatasi in tutta Europa la restaurazione postnapoleonica, i germi liberali della rivoluzione francese erano ormai penetrati nell’animo di vari settori delle società e, impulsate da un forte spirito libertario, erano presto sorte un po’ ovunque sette cospirative segrete – cui aderirono perlopiù membri della borghesia, della nobiltà liberale e dell’intellettualità progressista – miranti alla sovversione del nuovo ordine restaurato.
In Italia, il movimento sovversivo era costituito da massoni, ufficiali ex-murattiani, carbonari e altri settari inizialmente prolificatisi nel Regno delle Due Sicilie e successivamente anche nello Stato Pontificio, in Piemonte, in Toscana, a Parma, Modena e nel Lombardo-Veneto. Il lato debole – causa primaria del fallimento delle azioni rivoluzionarie – sarebbe poi risultato essere stata l’assenza quasi assoluta di legami organizzativi e strutturali con le masse popolari, quelle contadine in particolare. Dopo una serie di tentativi insurrezionali falliti sul nascere – alcuni proprio in Puglia – nella notte tra il 1º e il 2 luglio 1820, una ventina di carbonari, tra cui il prete Luigi Minichini, si unirono ad un gruppo disertore del reggimento borbonico di stanza a Nola – 127 soldati comandati dal tenente Michele Morelli e dal sottotenente Giuseppe Silvati – e si diressero su Avellino, riuscendo rapidamente a controllare la città e chiedendo al re Ferdinando I di Borbone la concessione della Costituzione sul modello di quella di Cadice del 1812, già nel marzo ripristinata in Spagna.
Qualche giorno dopo, il generale Guglielmo Pepe fece insorgere due reggimenti di cavalleria e uno di fanteria di stanza a Napoli e si diresse verso Avellino congiungendosi con gli altri insorti e assumendo il comando di tutte le forze ribelli. Il 6 luglio, Ferdinando I acconsentì alla formazione di un governo costituzionale e nominò il principe ereditario Francesco duca di Calabria, vicario del regno, e questi decretò la pretesa costituzione. Ben presto però, il re Borbone fu protagonista di un clamoroso voltafaccia e invocò l’aiuto austriaco, dichiarando di essere stato costretto a concedere la costituzione con la forza, e per gli Austriaci non fu difficile marciare su Napoli, occupare la città e poi il resto del regno. Così, la fragilissima esperienza democratica durò meno di un anno e sotto la pressione politica e militare delle corti d’Europa la costituzione fu abrogata nel marzo del 1821. Seguì una dura repressione, voluta da re Ferdinando I – per estirpare fin dalle radici tutte le sette cospiratrici – con il ritorno a capo della polizia del regno del già famigerato Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa.
La Puglia fu pienamente coinvolta in quel processo insurrezionale. Foggia fu una delle prime città del regno ad insorgere e nella vicina San Severo venne creato un deposito d’armi e un centro di collegamento con gli insorti. Anche a Brindisi, ed in tutta la provincia di Terra d’Otranto, gli echi della rivolta trovarono immediato riscontro. Francesco Palma era il sindaco, Giuseppe Maria Tedeschi era l’arcivescovo e il sottintendente era Ciriaco Andreace, con Giuseppe Ceva-Grimaldi marchese di Pietracatella intendente della provincia di Terra d’Otranto.
Il 16 gennaio di quell’anno era stato incarcerato nel bagno penale di Brindisi il sovversivo Alessandro Romano di Patù e il 5 aprile era stato scoperto un libello rivoluzionario sotto un avviso teatrale, mentre altri ne erano stati affissi clandestinamente sulla Rua Maestra: solo gli ultimi di una lunga serie di fatti che negli anni immediatamente precedenti – successivi agli eventi del 1817 in cui si era distinto l’ancor giovane Giovanni Crudo – erano stati sintomatici del clima e del sentimento politico che in città si respiravano in segretezza.
Così, quando l’11 luglio vi fu la lettura della costituzione concessa dal re con cerimonia in Cattedrale e discorso dell’arcivescovo Tedeschi, Giuseppe Capece – già distintosi nelle agitazioni del 1817 – fece cucire una bandiera tricolore con gli emblemi carbonari che fu issata sul Forte a mare dal vecchio Carlo Marzolla accompagnato da Francesco d’Oria capitano del Lazzaretto del porto, scalmanato settario come il suo compagno Giovanni Crudo, all’epoca aderente alla setta dei Decisi, Maestro dei Liberi Piacentini e capo setta dei Filadelfi di Brindisi, e in in tale veste non rinunciò mai alle sue azioni sovversive: un attacco – con violenza e due soldati feriti – a una pattuglia del reggimento Real Corona, avvenuto in Brindisi nella notte del 17 novembre 1820, fu attribuito a Giovanni Crudo, Luigi D’Amico e Nicola Moricchio. Altri Brindisini indicati essere stati alla ribalta nelle manifestazioni di giubilo, furono Vito Montenegro, Pietro Magliano e Domenico Nervegna.
Quando nello stesso mese di luglio da Napoli si decretò istituire giunte provvisorie protettive della libertà di pensiero in modo che ogni individuo fosse libero di scrivere stampare e pubblicare le sue idee politiche, per la provincia di Terra d’Otranto fu nominato delegato di Brindisi Giuseppe Montenegro, figlio di Leonardo e Carmela Monticelli Cuggiò. Nelle elezioni indette a fine agosto per il parlamento costituzionale del regno, alla provincia di Terra d’Otranto d’accordo con il numero di abitanti – Lecce 83.661, Taranto 78.366, Gallipoli 78.167 e Brindisi 65.450 – spettarono in totale sei deputati, e per il Distretto di Brindisi risultò eletto il padre domenicano Vito Buonsanto di San Vito, antico agitatore del ‘99.
Quel parlamento però, avrebbe avuto vita molto breve, giacché l’esercito costituzionale napoletano guidato dal generale Guglielmo Pepe e rafforzato da numerosi volontari giunti da ogni parte, Brindisi inclusa, venne battuto e sbandato il 7 marzo 1821 dall’esercito austriaco del principe di Metternich. Mentre a Brindisi proprio il giorno prima, il 6 marzo ultimo giorno di carnevale, in casa del notaio Oronzo Nisi si era organizzata una mascherata al fine di risollevare il morale dell’esercito costituzionale in lotta contro gli invasori austriaci.
Il precedente 9 gennaio, ancora sindaco Francesco Palma, c’era stata una sottoscrizione volontaria tra i cittadini per far fronte ai bisogni della guerra che si approssimava, specificamente per il vestiario dei legionari che avrebbero dovuto combattere l’esercito austriaco invasore, inviato dagli stati della Santa Alleanza appena riunitisi a Lubiana per mettere argine alla costituzione concessa a Napoli. Congresso a cui aveva partecipato lo stesso Ferdinando I, ingannando sfacciatamente i suoi sudditi con la richiesta dell’intervento armato straniero.
Il 19 marzo si riunirono in parlamento 26 dei 98 deputati eletti e sottoscrissero una protesta contro l’invasione straniera, ma il 22 marzo gli Austriaci entrarono a Napoli e ristabilirono il governo assoluto borbonico. Nello stesso marzo, il ritorno in funzione dei ministri fedeli al re comportò condanne immediate per i liberali compromessi che avevano propugnato la costituzione; molti esularono e tra questi il brindisino Francesco Pennetta. Poi, il 7 maggio, l’intendente di Terra d’Otranto Vincenzo Guarini, informò del decreto reale secondo cui “in vista delle perplessità in cui si trovavano alcuni abitanti di ciascun comune, i quali presero parte alle passate vicende, si assicurava che qualora fossero dimentichi delle passate vertigini e fossero vissuti da onesti cittadini, non avrebbero sofferta molestia alcuna”. Ma la realtà fu, naturalmente, alquanto diversa.
In Terra d’Otranto, dove non v’erano gruppi in armi, si perseguirono le opinioni e il pensiero. Trentatré ufficiali e cento trentuno impiegati sarebbero stati destituiti: sacerdoti, notai, magistrati e altri funzionari amministrativi. Quando il 20 giugno 1821 il consiglio decurionale di Brindisi deliberò la formazione del corpo delle guardie civiche, precisò che, allo stesso modo che per qualsiasi altra nomina per impiegati comunali, non avrebbero potuto farne parte coloro che fossero appartenuti alle proscritte società segrete.
E a Brindisi di settari evidentemente ce n’erano ancora parecchi: il 21 giugno, festa del Corpus Domini, mentre il vescovo monsignor Tedeschi – notoriamente filoborbonico e reazionario – andava a cavallo in processione, un gruppo di carbonari fece sparare due salve di cannone per spaventare il cavallo, sapendo di porre in tal modo in seria difficoltà il vescovo e potersi quindi burlare apertamente di lui.
La notte del 26 giugno, un gruppo di quattro carbonari molto compromessi con i fatti del 1820 – i brindisini Francesco Del Buono, Luigi D’Amico, il sacerdote Santo Chimienti e il gallipolino Francesco Bianchi – aveva pianificato di fuggire da Brindisi su un’imbarcazione greca battente bandiera inglese, ma qualcuno aveva fatto da spia e la polizia aveva teso loro un’imboscata. Mentre in piena notte i fuggiaschi si avviavano all’appuntamento con il bastimento che li avrebbe espatriati preceduti da Antonio – fratello del sacerdote che seguito da un contadino con un asino carico di bagagli faceva da battistrada – e questi s’imbatté per primo nelle guardie e lanciò l’allarme facendo sì che tutti potessero darsi alla fuga dileguandosi nella notte, imbarcazione compresa. Invano le autorità si adoperarono per far parlare l’unico arrestato Antonio Chimienti il quale, infine, dopo quattro mesi di prigionia, fu liberato.
In ottobre a Lecce, la giunta di scrutinio della provincia di Terra d’Otranto condannava sommariamente decine di funzionari rei d’aver parteggiato per la costituzione liberale, e di Brindisi furono immediatamente destituiti: Francesco D’Oria capitano del Lazzaretto, Oronzo Nisi notaio, Giuseppe Domenico Resta cancelliere del giudicato, Lucio Alessano chirurgo della Regia Marina, Antonio d’Ippolito ricevitore del registro, Giuseppe De Cesare cancelliere comunale.
Il 28 febbraio 1822, finalmente, il re decretò l’indulto per i politici compromessi, che per certo doveva ancora riguardare non pochi Brindisini, per lo meno a giudicare da quanto rapportava il sottintendente Luigi De Marco il 14 giugno di quell’anno: “Giovanni e Gennaro Del Giudice, Raffaele De Angelis, Cosimo Guadalupi esattore della fondiaria, Agostino Fedele caffettiere, Giuseppe e Salvatore Tadisi, Giuseppe Domenico Resta ex cancelliere del giudicato, Francesco De Pace, Bartolomeo Braico, erano tutti faziosi sorvegliati dalla polizia”.
Nelle linee precedenti, all’incirca una trentina di nomi brindisini e certamente altri, forse almeno altrettanti, quelli che non trapelarono: non pochi per una città di provincia che allora contava con solamente 6.000 abitanti. Come se ad oggi di settari se ne contassero a Brindisi quasi un migliaio. Ed in effetti, quei sentimenti liberali progressisti e persino rivoluzionari, erano stati solo momentaneamente acquietati, ma non certo debellati, come ebbe modo di relazionarlo direttamente al nuovo re Francesco I lo zelante funzionario regio Giovan Luca Vezii il 22 dicembre 1825: “…Nelle province del regno si riorganizzano e si estendono le fila settarie e quella diffusa in Terra d’Otranto è dominata dagli edennisti, detta delle otto lettere o dei quattro colori. Ha per oggetto di abbattere la religione, il trono reale, ed ergere il governo repubblicano… Quella vasta e interessante provincia ha la disgrazia di non avere buoni sottintendenti, giacché quello di Brindisi Luigi De Marco, oltre ad essere vecchio, è anche poco esperto, per cui dovendosi fare manodurre da altri, accade che si fa illudere e porta un silenzio sopra gli affari più rilevanti, e ciò pregiudica al vostro real servizio”.
In effetti, a Brindisi nel 1826 furono operate perquisizioni nelle case di Giovanni Crudo, sorvegliato speciale, Antonio De Marzo, Giovanni Giaconelli, Vincenzo ed Antonio De Pace, del notaio Oronzo Nisi e di altri. Nonché nella farmacia di Vito Montenegro e Carlo Berardi, secondo il sottintendente frequentata da settari di ogni condizione, e nei caffè di Francesco Palmisano, Federico Provenzano e Francesco Manes “nei quali oziava più di qualche conoscenza della polizia e dove fra una partita e l’altra si sparlava del governo”. E così, tra una sedizione e l’altra, e tra una repressione e l’altra, anche a Brindisi sarebbe arrivato il 1830-31 e poi il 1848, con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e con le loro gesta rivoluzionarie ancora una volta finalmente e spietatamente represse dall’assolutismo. Tutte storie che però, esulano dal racconto di questo episodio.
