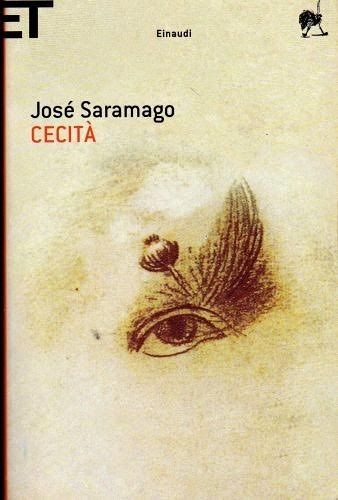
Per me leggere un libro è ogni volta un’esperienza nuova ed unica. Mi coinvolge totalmente.
La sensazione è quella di una sorta di frenesìa.
Non vedo l’ora di tirare qualcun altro dentro questa rete magica che si chiama appunto “trama”.
I personaggi, gli ambienti, le vicende mi rimangono addosso come un tatuaggio permanente e non sempre indolore.
Non posso iniziare subito un’altra storia, perché la prima deve decantare, evaporare un po’. Perché, come nella vita, anche la lettura va affrontata con serietà e rispetto: non si può essere approssimativi, né superficiali.
Nel frattempo, prima di iniziare una nuova storia, sento la necessità impellente di parlare del libro che ho appena terminato: lo consiglio, invito a comprarlo, lo presto.
Un’emozione dura di più se viene condivisa.
E’ il caso del libro che vi propongo oggi.
Il titolo italiano è “Cecità” (quello originale ”Ensaio sobre a Cegueira” ovvero ”Saggio sulla cecità”), l’autore, premio Nobel per la letteratura 1998, è José Saramago.
“Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono”
(la moglie del dottore – protagonista)
Si capisce immediatamente che la “cecità” a cui l’autore fa riferimento è l’allegoria di un’altra cecità: quella della ragione, della mente, della privazione dell’umanità.
La vicenda è sospesa nel tempo e nello spazio.
Traffico dell’ora di punta. Il semaforo rosso diventa verde.
Le auto partono tutte tranne una.
Inizia il delirio dei clacson e degli improperi.
L’auto non si muove. Tutti pensano ad un guasto.
“Alcuni conducenti sono già balzati fuori, disposti a spingere l’automobile in panne fin là dove non blocchi il traffico, picchiano furiosamente sui finestrini chiusi, l’uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato, dall’altro, si vede che urla qualche cosa, dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola, non una, due, infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno, finalmente, riesce ad aprire uno sportello, Sono cieco”.
Una strana forma di cecità: il dottore non è immerso in un buco nero, ma galleggia in una dimensione lattea. “Vede” tutto bianco.
“È come se stessi in mezzo a una nebbia, è come se fossi caduto in un mare di latte, Ma la cecità non è così, disse l’altro, la cecità dicono sia nera, Invece io vedo tutto bianco. […] Si ritrovava immerso in un biancore talmente luminoso, talmente totale da divorare, più che assorbire, non solo i colori, ma le stesse cose e gli esseri, rendendoli in questo modo doppiamente invisibili. […] Vedo lo stesso bianco, per me è come se la notte non ci fosse. […] Come in un lenzuolo bianco. […] E mi dice che è avvenuto all’improvviso, Sì, dottore, Come una luce che si spegne, Più come una luce che si accende. […] Dice di vedere tutto bianco, una specie di biancore latteo, che gli si attacca, spesso, che gli si attacca agli occhi. […] Per costoro la cecità non significava vivere banalmente circondati da tenebre, ma all’interno di uno splendore luminoso”.
Dopo di lui la cecità, come un’epidemia, si diffonde e colpisce un gran numero di abitanti.
Il fenomeno è inspiegabile: nessuna malattia conosciuta, nessuna contaminazione contro la quale si possa combattere.
All’impotenza si sostituisce la lotta per la sopravvivenza nel caos più totale.
“Il sonno della ragione genera mostri”, scrisse Francisco Goya nella sua celebre acquaforte alla fine del Settecento. E questa frase sintetizza benissimo il senso di quello che accade nella storia narrata da Saramago che, attraverso la potenza simbolica della lingua e agli espedienti narrativi, dà al lettore (soggiogato dalla sua scrittura senza punteggiatura, senza soste né respiro) il senso chiaro e drammatico della precarietà della condizione umana.
Ogni forma di dignità è annullata.
Per arginare l’epidemia, i ciechi vengono isolati e rinchiusi (dai pochi che ancora ci vedono) in un vecchio manicomio sotto la stretta sorveglianza dell’esercito.
I personaggi non hanno nome: la moglie del medico, la ragazza dagli occhiali scuri, il bambino strabico, il vecchio con la benda nera. Ciascuno di essi incarna una tipologia umana in cui si possono identificare tutti o nessuno.
Una sola donna resta immune dal contagio. E’ l’unica del gruppo a vedere mentre gli altri sono ciechi. Tuttavia quello che vede è violenza e degrado. Gli abitanti hanno perso gradualmente la propria umanità e sono diventati peggio degli animali.
All’interno dell’ospedale, la vita è resa impossibile dal sovraffollamento e dalla scarsità di cibo.
“Non dimenticarti di quello che siamo, ciechi, semplicemente ciechi, ciechi senza retoriche né commiserazioni, il mondo caritatevole e pittoresco dei poveri ciechi è finito, adesso è il regno duro, crudele e implacabile dei ciechi”.
Gradualmente però il contagio si diffonde ancora…
Josè Saramago (1922–2010) è un autore che appassiona il lettore attento. Il suo particolare stile di scrittura, privo dei nomi propri dei personaggi e della punteggiatura e virgolettatura dei dialoghi che abbiamo imparato a scuola, si legge tutto d’un fiato, senza possibilità di distrazioni.
Giusy Gatti Perlangeli
